Sui social la rabbia non è più solo un’emozione, ma un nuovo modello di business che consente a influencer e piattaforme di guadagnare più facilmente grazie all’engagement e all’indignazione del pubblico. Post e video pensati per dividere o far discutere moltiplicano le visualizzazioni e, con esse, i guadagni. Questo fenomeno, noto come rage baiting, è diventato una vera strategia per influencer e creator, ma apre questioni delicate: fino a che punto è lecito monetizzare l’indignazione altrui? E quali sono i rischi legali di chi lucra sulla rabbia?
Indice
Rage baiting, l’economia dell’indignazione
Il rage baiting è una tecnica manipolativa che mira a suscitare indignazione e rabbia tra gli utenti, con l’obiettivo di aumentare il traffico online, l’engagement e le entrate dei creator. Esempi di questo fenomeno sono presenti su Facebook, ma soprattutto su Instagram, Youtube e Tiktok, dove gli influencer, consapevoli o meno, sfruttano le reazioni negative degli utenti per farsi conoscere e aumentare la loro notorietà.
Così sono nati i contenuti sulla pizza con l’ananas, gli spaghetti spezzati e tutti quei brevi video che toccano temi culturali o sociali particolarmente sensibili. In alcuni casi, ancora più estremi, vengono realizzare delle interviste ai creator, nelle quali le risposte vengono completamente stravolte ed estremizzate per rendere il contenuto ancora più virale.

“Non possiamo parlare di un vero e proprio modello di business della rabbia — spiega l’avvocato Giacomo Conti, esperto di diritto applicato al digitale e all’informatica, privacy e protezione del dato personale, e delle piattaforme digitali —, ma di una deviazione patologica dell’economia dell’attenzione. Le piattaforme guadagnano dall’engagement: più interazioni significano più pubblicità”.
Il modello di business basato sulla rabbia
Mentre in Italia iniziano a diffondersi i cosiddetti “influencer rage bait”, negli USA il modello è già consolidato. Winta Zesu, una youtuber americana, ha ammesso di guadagnare oltre 150.000 dollari interpretando il ruolo della ragazza bella e superficiale, provocando le reazioni degli utenti attraverso la sua apparente vanità.
In Italia un esempio concreto è l’influencer torinese Michelle Comi, spesso al centro di polemiche: i commenti indignati ai suoi video ne aumentano la viralità e, di conseguenza, gli introiti. In alcuni casi il guadagno deriva persino dalle denunce per diffamazione contro gli utenti che oltrepassano i limiti.
“Il diritto di critica è legittimo — osserva Conti — solo se rispetta i canoni di pertinenza, continenza e verosimiglianza. Reagire con rabbia può costare caro: i reati di diffamazione a mezzo social sono sempre più frequenti e aggravati dal mezzo utilizzato”.
Rischi e limiti legali del rage baiting
Il fenomeno del rage baiting solleva interrogativi anche sul piano normativo. Secondo Conti, “il problema non è la mancanza di norme, ma la loro efficacia”.
Le grandi piattaforme sono soggette al Digital services act e al regolamento Platform2Business, che impongono obblighi di controllo dei contenuti. Tuttavia, spiega l’avvocato, “far valere i propri diritti contro le big tech è difficile: i tempi della giustizia sono lenti e i costi elevati. Le piattaforme spesso hanno un interesse economico a non bloccare contenuti virali, anche se borderline”.
Sul piano commerciale, invece, non è da escludere la responsabilità del brand: “Il caso PandoroGate ha segnato un punto di svolta. Le aziende dovrebbero chiedere ai creator di aderire a un codice etico e inserire nei contratti regole di condotta precise. Affidarsi a influencer polarizzanti può portare visibilità immediata, ma danni d’immagine nel lungo periodo”, aggiunge.
Il dibattito resta aperto: è giusto guadagnare dall’indignazione collettiva? Secondo l’avvocato Conti, “viviamo in un’epoca eccessivamente normata: esistono, a titolo di esempio, il GDPR, l’AI act, il Regolamento Platform2Business, il regolamento Digital service act e Digital market act, il Data act, il Regolamento 2018/1807, oltre alle normative nazionali e gli atti di soft law delle autorità di settore”. L’elenco potrebbe essere addirittura più lungo se considerassimo anche i regolamenti contrattuali delle singole piattaforme.
“Servono meno leggi e più educazione digitale e soprattutto emotiva – conclude l’esperto –. Imparare a gestire la rabbia online è il modo migliore per non diventare vittime di chi la sfrutta per profitto”.

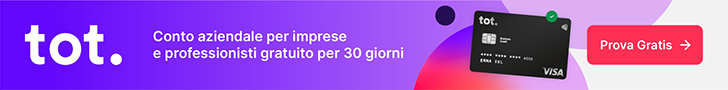
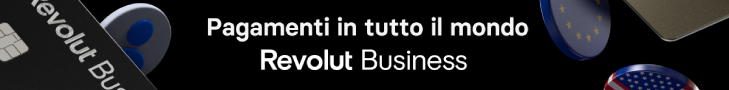

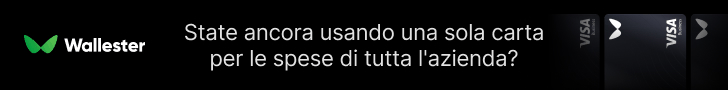









Laura Pellegrini
Giornalista e content editor