In Italia, se sei una donna hai circa il 52,5% di probabilità di lavorare, contro il 70,4% degli uomini. E se vivi al Sud, quest’opportunità può addirittura scendere sotto il 30%, come in Campania e in Sicilia. A pesare su queste statistiche anche gli stereotipi di genere che, nel mondo del lavoro, trovano le loro motivazioni più profonde nella fragilità del welfare, nelle resistenze culturali patriarcali che delegano in via esclusiva al genere femminile la cura dei familiari non autosufficienti e affermano il potere degli uomini sulle donne, ma anche nelle nuove tecnologie – come l’intelligenza artificiale – che frenano il cambiamento. Gli algoritmi sembrano “addestrati” per consolidare pericolosi bias cognitivi, anziché superarli. Partitaiva.it ha individuato gli stereotipi di genere più frequenti a lavoro e le occasioni in cui l’AI non incentiva le pari opportunità.
Indice
Differenze di genere in Italia, le donne lontane dall’indipendenza economica
In Italia il tasso di occupazione, nel 2024, è aumentato ma non ha raggiunto neppure l’omogeneità sul territorio nazionale: al Nord è del 62,8%, al Centro del 59,9% e nel Mezzogiorno del 37,2%. Anche coloro che lavorano non possono contare sulla stessa disponibilità economica degli uomini. Già nel 2022, secondo i dati forniti dall’ISTAT, la retribuzione oraria media era di 15,9 euro per le donne e di 16,8 euro per gli uomini; la retribuzione lorda annua, invece, differiva addirittura di 6 mila euro, a favore sempre del genere maschile.
Secondo una ricerca condotta dal Museo del risparmio di Torino, in collaborazione con Episteme e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, il 63% delle donne italiane dichiara di percepire un reddito. Tuttavia, solo il 15% ha un conto corrente intestato esclusivamente a proprio nome, mentre il 67% ha un conto cointestato con il partner o un familiare. Il restante 18% non possiede alcun conto corrente, neppure cointestato. Tutti numeri che confermano la resistenza culturale del patriarcato, che non lascia alle donne la stessa autonomia decisionale degli uomini, che passa soprattutto dall’indipendenza economica.
Donne a lavoro, il gap di genere nei singoli settori
Dall’analisi dei dati ISTAT e CNEL, emerge che la metà delle donne occupate si concentra in sole 21 professioni, mentre gli uomini si distribuiscono in 53 mestieri diversi. Alle donne sembrano destinati i ruoli di cura e igiene anche fuori da casa: si tratta per lo più di insegnanti, infermiere, operatrici socio-sanitarie, segretarie, addette alle pulizie, assistenti sociali. Al contrario, ci sono settori con una netta predominanza maschile come, per esempio, l’ingegneria, la tecnologia dell’informazione, il settore manifatturiero, l’edilizia e le estrazioni.
Secondo la classifica stilata dal decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2025, il tasso di disparità uomo-donna raggiungerebbe il suo massimo proprio nel settore delle estrazioni (82,2%), in quello delle costruzioni (81,9%) e nei trasporti (56,4%). A seguire, nella black list, c’è il settore agricolo, con un tasso di disparità del 47,9%, e il manufatturiero (46,3%). Tra il 40 e il 38% si trovano il commercio, le attività professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di informazione e comunicazione, le attività finanziarie e assicurative e persino quelle immobiliari. Insomma, fuori dal lavoro di “cura”, il genere femminile è sempre sottorappresentato.
Le competenze: donne più laureate degli uomini
Le differenze di genere non sono giustificate dai titoli di studio. Al 2023 risultava laureato oltre il 37% delle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni, contro il 30% degli uomini. E tra i lavoratori più giovani occupati, sono più frequentemente le donne a essere sovraistruite rispetto al ruolo ricoperto. A dirlo è lo studio presentato durante la 15esima Conferenza nazionale di Statistica. Persino la scelta dell’università, tuttavia, sembra soffrire delle influenze culturali. In particolare, sono le lauree STEM a essere quasi off limits per il gentil sesso: i giovani tra i 25-34 anni hanno una laurea STEM nel 37% dei casi, contro il 16,8% delle giovani che, in ogni caso, guadagnano dopo la laurea il 12,6% in meno dei colleghi.
Le STEM? “Sono per gli uomini”
Dall’indagine ISTAT (2023) su stereotipi e immagine sociale della violenza emerge che il 21% degli intervistati ritenga che i ragazzi siano “più portati delle ragazze” in questi ambiti. Quasi il 30% dei ragazzi condivide questa idea, contro poco meno del 13% delle ragazze. L’età, invece, sembra incidere molto meno. “Stereotipo non da poco e convinzione tutt’altro che banale. Le radici di questa disparità sono profonde e culturali. Il condizionamento agisce già in età scolastica, influenzando le scelte formative e, di conseguenza, l’accesso al mercato del lavoro di questi settori”, fa sapere Laura Basili, founder di Women at Business, piattaforma basata su un algoritmo di matching avanzato che promuove l’inclusione e le pari opportunità nel mondo del lavoro.
Secondo l’esperta, che il prossimo 30 settembre parteciperà allo STEM Woman Congress a Torino, che si concluderà il 15 ottobre con la finale milanese, questo comporterebbe una sorta di reazione a catena: “La scarsità di figure femminili visibili e di role model nei ruoli chiave rende più difficile per le nuove generazioni immaginarsi in quelle posizioni, alimentando la percezione che la tecnologia sia un ambiente poco accogliente – continua -. Comunque il livello di istruzione della famiglia d’origine gioca un ruolo importante. Se la madre ha un titolo universitario o di dottorato, la presenza di stereotipi si riduce sensibilmente, con un tasso del 19%, rispetto alla media del 21%”.
Il valore della realizzazione professionale? “Uguale per tutti”
Secondo la founder di Women at Business, un altro stereotipo diffuso sarebbe quello relativo al desiderio di realizzazione professionale: la carriera sarebbe un aspetto più importante per un uomo che per una donna. “L’idea di fondo è che la realizzazione femminile debba passare soprattutto dalla famiglia, dalla maternità o dalla cura degli altri, relegando la carriera a un ruolo secondario, utile solo come supporto economico o come attività accessoria”, aggiunge.
Oltre al fatto che espressioni e desideri dipendano anche dai condizionamenti culturali, oggi non esiste prova alcuna del fatto che le donne, tout court, “sentano” meno l’esigenza di realizzarsi professionalmente, né di escludere particolari discipline o settori dal proprio percorso. “Piuttosto, nell’ambito delle tecnologie sappiamo che quando i team di sviluppo sono eterogenei per genere, esperienze e provenienze, i risultati che ne derivano sono più inclusivi e in grado di rispondere a un pubblico più ampio. La presenza delle donne aiuta a intercettare i bias già nelle fasi iniziali di progettazione, migliorando la qualità e l’equità dei prodotti finali”.
Differenze di genere, ecco come l’AI discrimina le donne
Un recente report dell’ILO–NASK evidenzia come l’intelligenza artificiale generativa stia trasformando il mercato del lavoro in modo diverso per uomini e donne. Perché gli algoritmi, restituendo risultati di calcolo su dati esistenti già distorti dai bias, replicano di fatto vecchi pregiudizi. È quello che accade, ad esempio, con i software di selezione automatica del personale che tendono a penalizzare i curricula femminili per posizioni tecniche, o con gli assistenti vocali, che quasi sempre presentano voce femminile e impostazioni “servizievoli”, rafforzando immagini stereotipate. L’algoritmo di Women at Business, al contrario, è “No coded bias”: prende in considerazione solo le competenze professionali presenti nelle candidature con l’obiettivo di superare ogni stereotipo.
“Tra gli esempi più emblematici, gli algoritmi di riconoscimento facciale meno precisi sui volti femminili e di persone non caucasiche, i crash test automobilistici condotti con manichini che rappresentano solo corpi maschili e i dispositivi medici calibrati su parametri maschili, con conseguenze negative su diagnosi e terapie per le donne”, precisa Basili. Anche il giornalista e autore Simone Arcagni, professore della IULM, curatore e divulgatore che scrive di AI, new media e cultura, conferma questi dati. “Si tratta di un problema di tipo storico – fa sapere a Partitaiva.it -. Questi modelli si alimentano con dati che provengono dal passato e, statisticamente, per alcuni lavori l’accesso alle donne era sostanzialmente negato. L’AI è una macchina e, in quanto tale, classifica certe posizioni come non contemplabili come lavori per donne. Non ha uno storico femminile nel suo database e non può identificare qualcosa di diverso rispetto agli input che possiede”.
Superare il gender gap dell’AI
Il lavoro da fare dovrebbe essere quello di “ripulire” i dati di addestramento degli algoritmi e, contestualmente, di lavorare sul piano culturale all’interno della società, promuovendo l’inclusione. “Le donne che facevano calcoli manuali per i date frame c’erano anche prima, ma il loro lavoro era considerato esclusivamente come funzionale, di segreteria, e non certo di ricerca. Le donne, pur presenti, erano invisibili. Cosa c’è di diverso oggi? Che lo sappiamo”, prosegue Arcagni.
Tuttavia, secondo l’esperto, il problema risiederebbe nella “convenienza” di assecondare lo status quo. Per superare il problema, dunque, occorrerebbe un intervento di tipo normativo. “Una regolamentazione adeguata dei parametri etici secondo i quali un database va alimentato e un’analisi degli output può senza dubbio essere d’aiuto in questa fase – puntualizza l’esperto -. Un controllo normativo sui bias prodotti potrebbe prontamente rimuoverli. La fatica maggiore resta a livello culturale: nessuno dovrebbe sentirsi più legittimato ad accettare risultati che danno per validi e idonei solo dei profili maschili”.


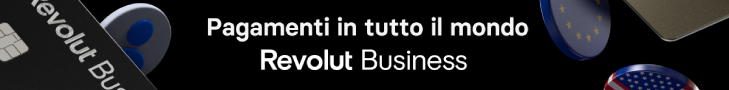
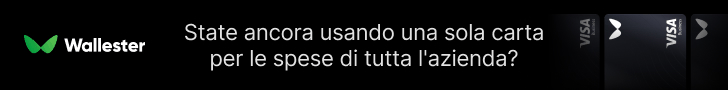











Natalia Piemontese
Giornalista