La settimana corta è l’ennesimo specchietto per le allodole con cui la politica e le grandi aziende fingono di innovare il mercato del lavoro italiano. Intesa Sanpaolo ne fa una bandiera di employer branding, Luxottica la vende come rivoluzione manifatturiera, la pubblica amministrazione la sperimenta in forma volontaria. Tutti parlano di work-life balance, benessere psicofisico, attrattività aziendale. Ma così si fa il conto senza l’oste: il problema non è quanti giorni lavoriamo, ma come lavoriamo. E soprattutto quanto produciamo davvero in quelle ore che passiamo seduti davanti a un computer o in piedi davanti a una macchina.
Indice
La produttività fantasma
I dati sono impietosi: la produttività italiana ristagna da trent’anni. Mentre le PMI tedesche hanno aumentato del 25,8% la produttività del lavoro nell’ultimo decennio, le nostre hanno fatto il 31,3%. Un dato apparentemente positivo, finché non si scopre che partiamo da livelli talmente bassi che anche crescere più velocemente non ci fa recuperare il divario accumulato negli ultimi trent’anni. L’intelligenza artificiale potrebbe aiutarci, ma anche su questo l’Italia resta indietro.
Siamo bravissimi a lavorare tanto – 47 ore settimanali per gli autonomi secondo Svimez, stakanovisti incalliti, costretti a fare straordinari per compensare salari miseri – ma drammaticamente incapaci di lavorare bene. Gli italiani lavorano più degli europei, ma guadagnano meno e producono meno valore per ogni ora lavorata. Non è un problema di impegno, è un problema di sistema.
La settimana corta presuppone un’organizzazione aziendale efficiente, processi snelli, management capace di valutare i risultati invece di contare le presenze. Presuppone investimenti in tecnologia, automazione dei compiti ripetitivi, formazione continua del personale. Presuppone cultura d’impresa orientata agli obiettivi, non alle ore di presenza. Presuppone esattamente ciò che manca alla maggior parte delle imprese italiane.
Settimana corta, chi può permettersela e chi no
Luxottica può permettersi di “sperimentare” nuovi modelli perché ha margini da multinazionale e strutture da industria 4.0. Dal 2024 ha avviato la settimana corta per 600 operai con 20 settimane all’anno di quattro giorni lavorativi, dal lunedì al giovedì, con venerdì libero e stipendio invariato. Il risultato? Soddisfazione generale e richieste raddoppiate per il 2025.
Intesa Sanpaolo può farlo perché nel settore bancario la digitalizzazione è già realtà consolidata. Oltre il 70% dei dipendenti ha aderito al modello 4×9 (quattro giorni da nove ore), con estensione progressiva a centinaia di filiali. L’80% del personale lo ritiene “innovativo” e fondamentale per il benessere.
La realtà quotidiana delle imprese italiane
Le PMI industriali italiane – che sono il 75% del tessuto produttivo del Paese – affrontano già una pressione fiscale superiore di 5,8 punti rispetto alle grandi imprese, costi energetici insostenibili, concorrenza low-cost cinese e burocrazia asfissiante. Cosa dovrebbe fare un’azienda meccanica veneta con venti dipendenti, margini del 3%, clienti che pagano a 120 giorni dalla fattura e un carico fiscale che toglie il respiro?
Dovrebbe assumere personale per coprire i turni del quinto giorno? Con quali soldi, considerando che, secondo Mediobanca, le differenze fiscali hanno inciso per oltre 6 miliardi nell’ultimo decennio sulle medie imprese? Aumentare i prezzi? In un mercato dove circa il 70% delle imprese segnala la presenza crescente di operatori stranieri dai costi competitivi, specie dalla Cina? Investire in automazione? Con quale accesso al credito, in un Paese dove le PMI faticano a capitalizzarsi?
La verità è che la settimana corta rischia di diventare l’ennesimo privilegio per chi già gode di un trattamento “di favore”, mentre la maggioranza degli occupati italiani continuerà a fare i salti mortali per arrivare a fine mese. Non è un caso che le sperimentazioni riguardino quasi esclusivamente grandi gruppi e settori ad alta marginalità. Le imprese familiari, che costituiscono l’osso duro del Paese, non possono permettersi questi esperimenti.
La cultura del presenteismo
Poi c’è la questione culturale. In Italia confondiamo sistematicamente il tempo passato in azienda con l’impegno lavorativo. Fatta eccezione per i pochi assenteisti, abbiamo una cultura del presenteismo patologico, dove chi esce dall’ufficio alle 18 è considerato meno dedito al lavoro di chi resta fino alle 20, indipendentemente da cosa abbia effettivamente prodotto.
Riunioni infinite senza conclusioni operative, e-mail che girano in copia a mezza azienda senza che nessuno si prenda la responsabilità di decidere, processi decisionali bizantini dove servono tre livelli di approvazione per comprare una risma di carta: la burocrazia interna alle imprese private replica quella pubblica. E vorremmo risolvere tutto concentrando questo caos su quattro giorni, invece che cinque?
Il problema non è la durata della settimana lavorativa. È che in moltissime aziende italiane non esiste una vera cultura della produttività: non si misurano gli obiettivi, non si valutano i risultati, non si premia l’efficienza. E si finisce per contare solo le ore, le presenze e la disponibilità a restare oltre l’orario di lavoro. Ma il cambiamento e la formazione manageriale non si comprao con gli sgravi contributivi.
La proposta di legge sulla settimana corta in Italia
Il 1° ottobre 2024, su iniziativa dei deputati Fratoianni, Conte, Bonelli, Schlein e altri, è stata presentata la proposta di legge n. 2067 sulla settimana corta. Prevede una riduzione progressiva dell’orario di lavoro fino a 32 ore settimanali, anche su quattro giorni, a parità di salario. L’incentivo previsto è l’esonero contributivo del 30% per i datori privati (esclusi agricoltura e lavoro domestico) per 36 mesi, che sale al 50% per le PMI. La copertura immaginata nel 2024 era di 50 milioni nel 2024 e di 275 milioni per il 2025 e 2026.
Il presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, ha bloccato l’iter a febbraio 2025 rinviando il testo in commissione senza mandato a riferire. Le obiezioni della maggioranza riguardano il peso della misura per le casse dello Stato. Ma c’è un problema ancora più grave. L’articolo 6 della proposta prevede che dopo tre anni l’orario normale di lavoro venga ridotto per legge dove almeno il 20% dei lavoratori è coinvolto in contratti di riduzione: un automatismo che trasforma la sperimentazione in riforma strutturale obbligatoria, con il rischio di moltiplicare le crisi aziendali e, quindi, di tagliare i posti di lavoro che ancora resistono.
E mentre si discuteva se la settimana corta fosse sostenibile, a marzo 2025 Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il parlamento, ha proposto la settimana corta esclusivamente per i parlamentari, giustificandola con le “difficoltà logistiche” delle consultazioni. La proposta è caduta nel vuoto tra le polemiche, ma ha certificato l’ipocrisia di fondo: regole diverse per chi le scrive e per chi le subisce.
Il vero ostacolo è (ancora) la burocrazia
Impossibile non notare, da una parte, l’atteggiamento di uno Stato che fatica ad aggiornare gli stipendi pubblici, a garantire pensioni adeguate e misure di welfare a tutela dei contribuenti. Dall’altra, la cecità di chi crede di poter comprare con gli sgravi fiscali la capacità di ripensare un’organizzazione aziendale.
Perché i veri ostacoli alla produttività italiana sono da ricercare nella burocrazia che divora tempo ed energie con oltre un terzo delle PMI che evidenzia difficoltà di accesso ai programmi UE per transizione ambientale a causa dell’eccessivo carico burocratico, in un sistema formativo scolastico scollegato dal mercato del lavoro, nella pressione fiscale che penalizza proprio chi vorrebbe investire in innovazione.
Ammesso che lo Stato trovi i fondi necessari per la misura – e già questo è tutto da dimostrare – gli incentivi pubblici servono a poco se non cambiano prima mentalità e competenze manageriali, nel pubblico e nel privato. Non si può comprare con gli incentivi la capacità di misurare la produttività, di definire obiettivi chiari, di valutare i collaboratori sui risultati anziché sulle ore lavorate. Né si può pensare che la settimana corta basti a rendere più attrattive le imprese italiane, quando i giovani disposti a trasferirsi in altri Paesi possono trovarla già e contare pure su stipendi più alti.
L’esperienza internazionale
Chi osa contraddire la primaria necessità della settimana corta viene subito travolto dai cultori dei dati internazionali che sembrano sostenerla. In Islanda il primo test nel 2015 ha coinvolto 2.500 lavoratori con quattro giorni lavorativi per circa 35 ore settimanali. I risultati? Aumento della produttività e 86% dei dipendenti che ha preferito il nuovo modello. Nel Regno Unito, 61 aziende hanno sperimentato la settimana corta nel 2022-2023, notando riduzioni del 65% delle assenze per malattia, del 57% delle dimissioni e del 71% dei casi di burnout, mantenendo stabile il fatturato. Risultati simili sono stati ottenuti da Microsoft in Giappone.
Questi esempi, tuttavia, riguardano Paesi con livelli di produttività già elevati, culture aziendali mature, sistemi di welfare efficienti. L’Islanda ha 380.000 abitanti e un PIL pro capite tra i più alti al mondo. Il Regno Unito ha un’economia dei servizi avanzata e digitalizzata. Il Giappone, nonostante alcuni problemi strutturali, parte da livelli di efficienza organizzativa di grande rilievo.
In Italia, invece, secondo l’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano, solo il 13% dei lavoratori ha sperimentato la settimana corta, mentre il 78% aspira a farlo. Ma le aspirazioni non si traducono automaticamente nella capacità di realizzarle. Oltre alle competenze, poi, la settimana corta necessita della capacità di sostenerne i costi, talvolta elevati e di gran lunga superiori agli incentivi pubblici. Nei settori manifatturieri e nei servizi essenziali – sanità, trasporti, logistica – non basta concentrare le ore su quattro giorni e neppure diventare abili manager: servono sostituzioni, turni aggiuntivi, nuove assunzioni.
La settimana corta come benefit aziendale
La settimana corta può funzionare solo come conseguenza di un sistema produttivo già efficiente, non come sua premessa. Invece continuiamo a vendere l’idea che basti lavorare un giorno in meno per diventare improvvisamente più produttivi e più felici, come se il problema fosse quantitativo e non qualitativo. In sostanza, spacciamo per riforma del lavoro ciò che trattiamo come benefit aziendale, al pari dei buoni pasto, per attrarre nuovi talenti in un mercato sempre più competitivo che però ha sempre meno spazio per i giovani.
Il giorno in cui le imprese italiane lavoreranno davvero quattro giorni a settimana producendo più di prima, avremo risolto problemi molto più profondi della semplice organizzazione dell’orario: avremo investito in formazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica; avremo riformato la pubblica amministrazione, snellito la burocrazia, reso più efficiente la giustizia civile; avremo cambiato cultura manageriale, introdotto sistemi di valutazione basati sui risultati, formato una classe dirigente capace di guidare la trasformazione. Fino ad allora, continuiamo pure a sperimentare, ma senza prenderci in giro.


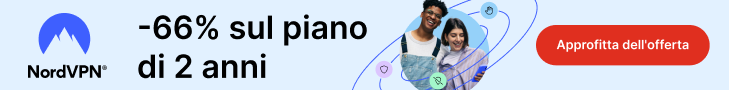
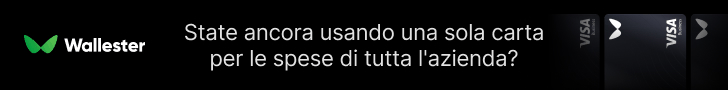











Ivana Zimbone
Direttrice responsabile