In Italia, su dieci euro prodotti da varie attività economiche, uno proviene da quella che si definisce economia sommersa. Ovvero da tutte quelle attività che sfuggono al controllo statistico e fiscale e di cui si riesce ad avere una stima attraverso altri metodi. Il sommerso include sia attività non dichiarate (comunemente dette “in nero”), sia illegali, come il contrabbando di tabacco e droga, la prostituzione, il caporalato. Dell’economia irregolare, in realtà, la quota del mercato criminale è “minima”. Il resto proviene dalle attività che sfuggono quotidianamente a quella che è l’economia “regolare”.
Indice
I numeri dell’economia sommersa in Italia: attività illegali vs attività irregolari
Stando agli ultimi dati aggiornati Istat, l’economia sommersa in Italia supera i 217 miliardi di euro di valore aggiunto, circa il 10,2% del Pil nazionale. La sola componente irregolare sfiora i 198 miliardi, pari al 9,2% del Pil dell’economia nel nostro Paese, mentre la quota dell’illegalità produce valore per 19,9 miliardi di euro, che spariscono nel nulla.
I numeri evidenziano un fenomeno in espansione, rispettivamente del 7,5% e dell’1% per quanto riguarda irregolare e illegale. A crescere, però, non sono solo le dimensioni del fenomeno, ma anche il numero di persone coinvolte: più di tre milioni di lavoratori risultano occupati non regolari o comunque assunti in modo irregolare per contenere i costi (ad esempio un full time dichiarato come part time). In pratica, un incremento di 145 mila unità nell’arco di un solo anno.
In aumento anche la sotto-dichiarazione, in particolare nei settori a più elevato contatto con il pubblico (e di pagamenti in contante), tra le pratiche più diffuse di evasione fiscale.
Economia sommersa, chi sono i responsabili
Ben evidente è il fatto che, trattandosi di sommerso – e quindi di valore prodotto “in nero”– non ci sono fonti ufficiali a cui poter far riferimento. Esistono tuttavia stime attendibili che elaborano fonti amministrative, conti nazionali e modelli statistici, che permettono una ricostruzione scientifica delle parti mancanti dei conti economici. Ad esempio, la differenza tra gettito atteso e reale nelle casse dello Stato, tra reddito disponibile e spese delle famiglie, flussi di contante (più facile da occultare) e via di seguito.
L’Istat include nell’economia sommersa diverse componenti: le imprese che riducono parte del fatturato o gonfiano i costi per pagare meno tasse; le attività che impiegano lavoratori in nero o in modo irregolare e i proventi da mance o fitti non dichiarati. “Pur contribuendo alla ricchezza e al reddito di uno Stato – spiega a Partitaiva.it Leonardo Battista, ricercatore di diritto del lavoro presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – sfuggono all’economia formale per occultare il valore economico della transazione, in virtù di un vantaggio economico”.

Battista presenta alcuni casi concreti. “Si pensi, ad esempio, alla vendita di un prodotto senza regolare ricevuta o alla prestazione lavorativa di un lavoratore senza alcun contratto di lavoro comunicato agli enti preposti. O ancora, il lavoratore pubblico con doppio lavoro, come nel caso delle ripetizioni e dell’aiuto compiti nel proprio domicilio – aggiunge -. E poi ci sono i lavoratori senza permesso di soggiorno e gli occupati dichiarati, ma irregolarmente trattati dal punto di vista economico, come accade spesso nella ristorazione, dove ci si ritrova a lavorare più ore rispetto a quelle dichiarate con parte della retribuzione in nero”.
Il gap tra Nord e Sud
Il fenomeno è più diffuso al Sud, dove la scarsa stabilità occupazionale, la ridotta presenza industriale e un tessuto produttivo fatto di microimprese rendono più difficile la piena emersione delle attività economiche. Calabria, Campania, Puglia e Sicilia sono tra le regioni con la maggiore incidenza del sommerso sul valore aggiunto.
Al Nord, invece, l’economia sommersa ha valori più contenuti, grazie alla presenza più forte di imprese strutturate e la maggiore frequenza di controlli, pur non essendo affatto trascurabile. Qui il fenomeno riguarda per lo più specifici settori, come la ristorazione, alcuni comparti manifatturieri e il lavoro domestico.
Cosa succede in Europa? L’esperto: “Mal comune”
Leonardo Battista, nel suo libro dal titolo Il lavoro sommerso e il ruolo dell’Autorità Europea del Lavoro, mette in evidenza come il “male” del lavoro sommerso non riguardi soltanto l’Italia. “La Commissione europea, sin dal 2019, ha dotato l’Autorità europea del lavoro del compito di sensibilizzare la lotta contro tale fenomeno, in tutti i 27 Stati membri, dato che nessuno ne è esente – aggiunge -. Diverse, infatti, sono le esperienze simili a quelle del nostro Paese, soprattutto in settori come l’agricoltura o la ristorazione, dove il vantaggio competitivo o il profitto si basano spesso proprio sulla mancata dichiarazione degli introiti o sul ricorso a forme di lavoro sommerso”.
L’esperto fa sapere che luoghi come Huelva o El Ejido in Spagna o Manolada in Grecia presentano esperienze di lavoro sommerso e irregolare in agricoltura estremamente rilevanti anche per la portata numerica dei soggetti che non riescono a trovare un lavoro diverso. Ma c’è di più. “In altri settori, come quello della logistica, abbiamo notizie di un costante ricorso al lavoro sommerso per garantire vantaggi alle aziende che trasportano merci su strada nell’Unione europea, sfruttando il mancato rispetto delle norme in materia di orario di lavoro degli autotrasportatori, sino ai casi più gravi di assenza di contratti di lavoro, di adeguate patenti di guida e di bolle di accompagnamento dei prodotti”, conclude.
La classifica dei settori più colpiti
L’economia sommersa continua a crescere in Italia per diversi fattori, come l’elevata pressione fiscale e contributiva, additata spesso come causa di sotto-dichiarazioni o forme d’impiego non regolari. Tra le attività in cui si concentrano maggiori irregolarità ci sono quelle dei servizi alla persona (come baby-sitting, estetica, piccola manutenzione e collaborazione domestica, l’assistenza familiare a domicilio). E poi ci sono il commercio, la ristorazione e il turismo. Significativa anche la presenza di lavoro sommerso nell’edilizia, settore caratterizzato da grande ciclicità, in cui il fenomeno riguarda sia la forza lavoro, sia l’utilizzo di fatture irregolari o gonfiate, una pratica che incide sulla concorrenza e sui prezzi di mercato.
Le conseguenze economiche e sociali
Se il problema principale dell’evasione fiscale riguarda il mancato gettito nelle casse statali, ci sono altri effetti che il fenomeno dell’economia sommersa genera. Tra questi la concorrenza sleale, dal momento che chi opera fuori dalle regole può permettersi prezzi più bassi rispetto a chi rispetta gli obblighi contributivi. E poi c’è la scarsa qualità del lavoro: lavoratori irregolari non hanno tutele, non godono del versamento dei contributi e sono esposti a rischi di sicurezza molto più elevati.









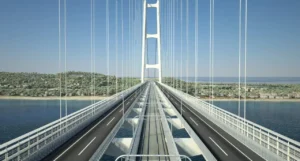
Natalia Piemontese
Giornalista